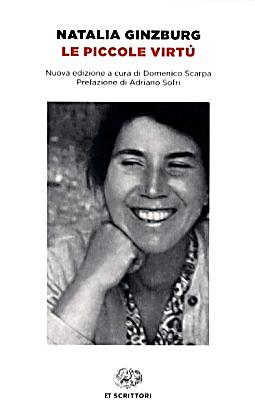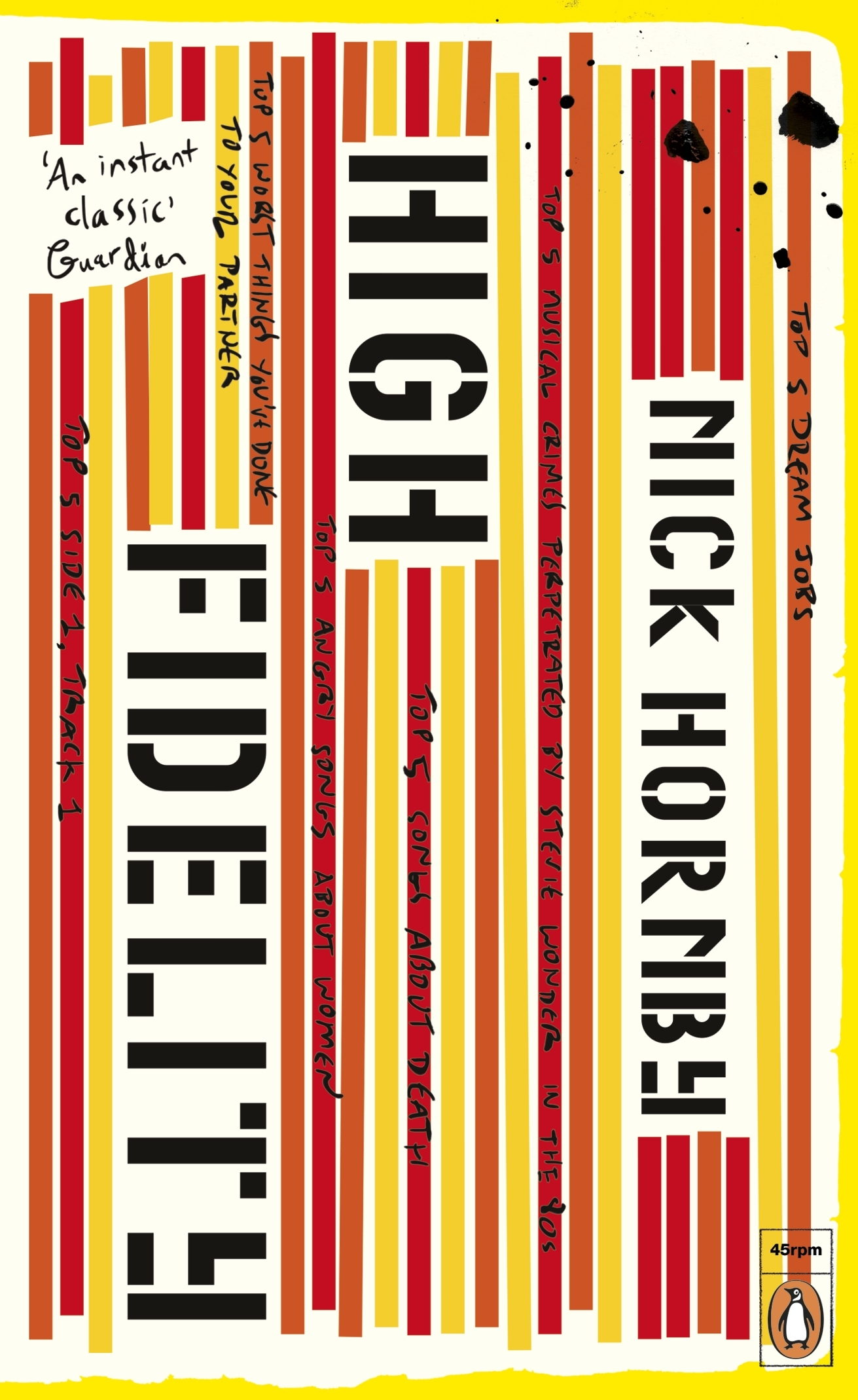«Non ho detto nulla se non quello che penso ogni volta che ripenso a lui: che mi ha fatto tanta compagnia, la migliore possibile, e gli sono grato. E che proprio come quando ti muore un amico, quel giorno, quell’anniversario, arriva sempre, di nuovo, si ripete e alla lunga non hai più molte parole, ma solo una certa commozione, e te la tieni stretta, in quanto testimonianza e ultime sembianze di quel legame.»
La prima volta che mi sono innamorata delle parole di Cesare Pavese mi trovavo nella piccola libreria della mia città – un miracolo anche quello, a modo suo: in un paesino di cinquemila abitanti e due lettori, un posto così era per lo meno sorprendente -; ricordo di aver afferrato un libro dalla costina bianca con sopra scritto “poesie” perché in quel periodo avevo scoperto Neruda e la Dickinson e avevo realizzato che non era poi così impossibile capirli. Ho aperto a caso, come sono solita fare (il volume era onnicomprensivo) e mi sono fermata su una delle poesie rimaste fuori dal grande collettore di Lavorare stanca. Ho iniziato a leggere ed è accaduto rapidamente, senza che potessi controllarlo: le mie gambe tremavano, il respiro diventava affannoso. Quella poesia mi aveva come afferrata in qualche organo interno, costringendomi ad andare fino in fondo e attraversare un’esperienza dolorosamente viva. Le parole scorrevano come una fiumana, quasi senza punteggiatura; era come un racconto, ma ridotto all’osso; grumi di disperazione e sogni e rassegnazione e amore e vita e morte si addensavano qui e lì. Sono passati almeno cinque anni da quando è successo, e una delle cose che rimpiango di più è non aver segnato quelle pagine. Ho letto e riletto le poesie di Pavese migliaia di volte, ma non sono mai più stata in grado di ricordare cosa mi abbia colpita quel giorno. Ma forse non è poi così importante, se penso al resto: e cioè al fatto che da quel giorno Pavese è diventato una presenza costante nella mia vita, prima in maniera furtiva e poi in maniera clamorosamente esibita. Le poesie sono state la mia coperta di linus per anni; le tenevo sul comodino e giorno dopo giorno scoprivo un uomo rabbiosamente ferito, disperatamente bisognoso di amore e di vita, «insaziabile». Quell’uomo riscaldava, a modo suo, le mie fredde giornate d’inverno: lo vedevo arrancare, poi prendere lo slancio verso una specie di sogno e di barlume di speranza (a volte ho pensato lui come a un Gatsby ormai disilluso), poi inciampare per terra, ormai solo, ferito, ansimante. «E io, piegato e distrutto, me la sento pulsare d’intorno formidabile e viva, ma l’ho anelata tanto che non ho ormai più forza di levare la fronte e fissarla e comprenderla. E mi accascio in un buio dolorante rabbiosamente a torcermi» (O ballerina bruna).
Pavese in realtà l’avevo conosciuto già qualche anno prima, quando la mia libraia di fiducia mi aveva messo nelle mani una copia vecchissima di La casa in collina senza darmi troppo modo di rifiutarmi. Quel libro l’ho iniziato controvoglia, sperando di terminarlo presto, e infatti non ho capito molto: ricordo la lentezza delle frasi, le Langhe, la solitudine e la malinconia di Corrado, la bellezza partigiana di Cate e poco altro. Non l’ho più riletto, come dice Alessio Forgione nel suo articolo. E infatti da lì non avevo mai più voluto leggere i romanzi di Pavese, credendo che non facessero per me. Poi un giorno ho scoperto un piccolo libriccino, Paesi tuoi: papà è andato a comprarlo in una libreria sperduta di un paese vicino; era Natale e l’ho letto davanti al fuoco. Era una storia rabbiosa, come quelle poesie in cui Pavese aveva vomitato il rancore del fallimento. C’era Gisella, questa ragazza bellissima che sembrava racchiudere in sé tutto il senso della purezza e della carne, e a un certo punto di lei il protagonista dice una cosa che mi era parsa di una tenerezza atavica: «allora mi viene vicino stretta, per farsi abbracciare, e mi guardava fisso come se la sua faccia non fosse la sua e volesse vedere come facevo a baciargliela». Ma in quel libro c’è anche la morte, il sacrificio, il destino che si compie e spazza via qualsiasi cosa; c’è la terra, coi suoi ritmi e con il fuoco. E quando si arriva alla fine sembra di aver assistito al compiersi inesorabile di un mito, di una storia ancestrale che racconta degli uomini tutto quello che c’è da sapere.
Ho combattuto per molti anni contro questo famoso 27 agosto; non volevo rassegnarmi a quel gesto che reputavo insensato, vigliacco. Per anni ho ripercorso lettere, pagine di diario, poesie, cercando di scoprire quando è stato che qualcosa si è rotto inderogabilmente. Forse credevo che scoprirlo mi avrebbe fatto soffrire di meno, o forse speravo di poterlo aggiustare in qualche modo. Nella mia mente da ragazza diciottenne non avrei mai voluto che Pavese se ne andasse. Non riuscivo ad arrendermi al pensiero che avesse mollato la presa, perché avevo sentito anche io, nitidamente, tutto quel dolore stanco e strascicato che emerge nelle pagine di diario, e forse inconsciamente non volevo che anche per me fosse quella la fine ultima e necessaria. Ma Pavese quel vizio assurdo lo provava da quando aveva diciotto anni, e già da molto tempo aveva scritto la sua apologia – «Ma perché prendersela tanto coi poveri suicidi?». Era convinto che ciascuno di noi avesse un destino, e il suo martellava come una tentazione affascinante e terrificante fin dal principio. Nelle carte precedenti al suicidio c’è la paura, dei tentativi di auto-convincimento; il dolore che invade come una fiumana, corpi che affogando tentano di mettersi in salvo; c’è Constance, la donna a cui per troppi anni, erroneamente, è stata imputata la fine di Pavese. E poi quattro frasi, laconiche, dolorose: «Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più». Quel gesto è esistito, e ormai ho capito che c’è poco da girarci attorno. È esistito perché Pavese lo ha voluto, perché in quel modo ha compiuto il suo destino. Si era preparato da anni ad affrontare la morte: la vedeva negli occhi di Constance e in tutti gli altri rapporti amorosi (aveva scritto a Bianca Garufi: «sei la terra e la morte»). E infine, quel 27 agosto, aveva raggiunto il punto discendente della propria parabola vitale. Quel giorno non c’era nessuno in città: non c’era Natalia, non c’era Calvino. Pavese moriva silenziosamente, nella solitudine che lo aveva seguito sempre come un’ombra. Aveva lasciato il suo testamento sul tavolo - i Dialoghi con Leucò – e sulla prima pagina un messaggio ridotto all’osso che invocava discrezione.
Sono passati 70 anni, 6 da quando l’ho conosciuto, eppure questo giorno mi porta sempre una sensazione di fastidio allo stomaco. Credo sia una sorta di nostalgia inconcludente, il desiderio frustrato di un qualche rapporto – uno qualunque – con un uomo che è diventato mio amico senza che l’abbia mai conosciuto davvero. Pavese mi ha regalato le parole per dare un nome a un mucchio di cose: la brama di vivere, la rassegnazione della perdita, il senso della casa, della terra; l’ansia febbrile di qualcosa che inizia, la desolazione cinerea di qualcosa che finisce. E oggi non riesco a pensare a quella stanza dell’Hotel Roma, a quello che è accaduto prima, alla sensazione che ha provato durante; preferisco immaginarlo mentre percorre incappucciato le vie di Torino, tutto torvo, ripiegato su se stesso, impegnato a rigirare nella mente un pensiero ossessivo. Così, l’ho ritrovato, un giorno, per caso, nelle righe di un libro di Natalia Ginzburg, la donna a cui sarò per sempre debitrice per avermi regalato il più bel Ritratto di un amico:
L’amico misurava la città col suo lungo passo, testardo e solitario; si rintanava nei caffè più appartati e fumosi, si liberava svelto del cappotto e del cappello, ma teneva buttata attorno al collo la sua brutta sciarpetta chiara; si attorcigliava intorno alle dita le lunghe ciocche dei suoi capelli castani, e poi si spettinava all’improvviso con mossa fulminea. […] Era, qualche volta, molto triste: ma noi pensammo, per lungo tempo, che sarebbe guarito di quella tristezza, quando si fosse deciso a diventare adulto: perché ci pareva, la sua, una tristezza come di ragazzo – la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Qualche volta, la sera, ci veniva a trovare; sedeva pallido, con la sua sciarpetta al collo, e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta; non pronunciava, in tutta la sera, una sola parola; non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Umiliati, noi ci chiedevamo se la nostra compagnia l’aveva deluso, se aveva cercato accanto a noi di rasserenarsi e non c’era riuscito; o se invece si era proposto, semplicemente, di passare una serata in silenzio sotto una lampada che non fosse la sua. […] È morto d’estate. La nostra città, d’estate, è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza; il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo; il fiume scorre piatto come una strada, senza spirare umidità, né frescura. […] Non c’era nessuno di noi. Scelse, per morire, un giorno qualunque di quel torrido agosto; e scelse la stanza d’un albergo nei pressi della stazione: volendo morire, nella città che gli apparteneva, come un forestiero.